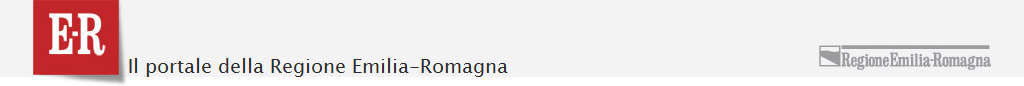Acque di transizione

SOTTO OSSERVAZIONE LE CONDIZIONI DI TROFIA
L’eccessiva presenza di sostanze nutritive, in particolare azoto, a seguito del dilavamento dei terreni determinato dalle precipitazioni atmosferiche, favorisce l’insorgenza di fenomeni eutrofici. Il giudizio di qualità per il fosforo ortofosfato è "buono" per tutti i corpi idrici di transizione, ad eccezione della Pialassa Baiona, per la quale tale giudizio è “sufficiente”. Per l'azoto inorganico disciolto (DIN), il giudizio di qualità è "sufficiente” per tutti i corpi idrici.

EPISODI DI IPOSSIA IN ALCUNE STAZIONI
Gli eventi anossici/ipossici, entro limiti tollerabili per la fauna e la flora residenti, sono condizioni definibili come “fisiologiche” per le acque di transizione. Durante il 2023, si sono verificati fenomeni di anossia frequente e/o persistente nei corpi idrici Valle Cantone, Valle Nuova e Pialassa Baiona. Tutti i corpi idrici delle acque di transizione, nel 2023, raggiungono lo stato "buono" per eventi anossici/ipossici, ad eccezione di Valle Cantone che risulta “sufficiente”.

ELEVATE CONCENTRAZIONI DI CLOROFILLA IN ALCUNI CORPI IDRICI
Nei corpi idrici di transizione possono svilupparsi intensi fenomeni eutrofici nel periodo primaverile/estivo, con elevate concentrazioni di clorofilla “a” in particolare nelle Valli di Comacchio. Nel 2023, l'indice di qualità MPI su corpo idrico, per la valutazione dello stato ecologico che comprende tale parametro e che considera anche la componente fitoplantonica, definisce "buono" Sacca di Goro, Valle Cantone e Pialassa Baiona, "sufficiente" Valle Nuova, “scarso” Lago delle Nazioni e "cattivo" Valli di Comacchio.

STATO ECOLOGICO CRITICO IN TUTTI GLI AMBIENTI
L’interramento di canali sublagunari, la scarsa circolazione delle acque, la riduzione degli scambi con il mare e l'immissione di nutrienti, in pochi decenni hanno portato a radicali cambiamenti nei popolamenti floristici e bentonici di tali ambienti. Ne consegue che, nella classificazione del sessennio 2014-2019, i corpi idrici Sacca di Goro, Valle Nuova e Pialassa Baiona hanno conseguito, per lo stato ecologico, un giudizio "scarso", mentre i corpi idrici Valle Cantone, Lago delle Nazioni e Valli di Comacchio hanno un giudizio "cattivo".

STATO CHIMICO, NON RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DI QUALITA’ BUONO
Per quanto riguarda lo stato chimico, si osserva che, a seguito dell'introduzione nella normativa ambientale di limiti più restrittivi per alcuni inquinanti e dell'analisi di nuove matrici come il biota, nel sessennio 2014-2019, tutti i corpi idrici di transizione non hanno conseguito lo stato chimico "buono".
Sintesi
Le acque di transizione rappresentano oggi aree marginali di un ecosistema un tempo diffuso in vasti territori costieri del nostro Paese e in tanti altri Stati rivieraschi, che si affacciano sul Mediterraneo.
Anche l'Emilia-Romagna presenta aree con tali condizioni particolari poiché, dall'inizio dell'ottocento, circa il 70% dei territori lagunari è stato bonificato.
Negli ambienti di transizione stazionano molte delle specie presenti negli elenchi delle specie minacciate. Gli stessi uccelli migratori trovano in questi habitat protezione e nutrimento. Un altro aspetto che va tenuto in considerazione è costituito dal potere di filtro che questi ecosistemi hanno nei confronti delle acque fluviali e drenanti del territorio. È ampiamente documentata la loro capacità di trattenere quote importanti di nutrienti (N e P) e di abbattere i carichi batterici, che altrimenti si riverserebbero direttamente in mare.
Ragioni dettate dalle vigenti direttive comunitarie e nazionali raccomandano e impongono la loro tutela.
In questo contesto assume una straordinaria importanza il ruolo della Regione e degli Enti locali territorialmente coinvolti, quello di Arpae Emilia-Romagna e dell’Ente Parco del Delta Po. Alla base di questo contesto di ruoli, vi è un’applicazione concreta dei principi previsti nelle linee guida della Gestione Integrata delle Zone Costiere approvata dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 643 del 20/01/05.
Classificare lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici di transizione, sulla base dei criteri tecnici definiti dal DM 260/10 e dal DLgs 172/15, permette di ottenere un quadro rappresentativo dello stato ambientale per le acque dei corpi idrici a livello di distretto idrografico, nazionale e comunitario. Lo stato di qualità ambientale "buono" corrisponde all'obiettivo di qualità da raggiungere ai sensi del DLgs 152/06. Per raggiungere tale stato, i corpi idrici devono risultare in stato "buono" sia sotto il profilo ecologico, che chimico.
La classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici deve prendere in considerazione gli esiti del monitoraggio di un intero sessennio; tuttavia l’attribuzione della classe di stato ecologico e di stato chimico avviene prevalentemente sulla base dei dati dell’ultimo triennio di monitoraggio. L’utilizzo dell’ultimo ciclo di monitoraggio per la classificazione è in relazione da un lato alle finalità delle diverse tipologie di monitoraggio (valutare nel tempo l’efficacia delle misure di tutela o le variazioni naturali o risultanti da una diffusa attività antropica) e dall’altra al fatto che l’adeguamento all’evoluzione normativa è un processo incrementale che ha maggiori probabilità di completarsi o realizzarsi nella seconda metà di un ciclo sessennale di attività.
Per quanto riguarda lo stato ecologico, si evidenziano criticità in tutti gli ambienti di transizione. In particolare, nel sessennio 2014-2019, Sacca di Goro, Valle Nuova e Pialassa Baiona conseguono uno stato ecologico "scarso", mentre i corpi idrici Valle Cantone, Lago delle Nazioni, Valli di Comacchio sono stati valutati come "cattivo". Gli elementi di qualità che incidono maggiormente sulla valutazione dello stato ecologico sono gli elementi di qualità biologica (EQB) macroalghe, macrobenthos e fitoplancton.
In relazione alle sostanze ricercate per lo stato chimico (tab. 1/A e 2/A del DLgs 172/15), osserviamo che, alla fine del sessennio 2014-2019, tutti i corpi idrici di transizione della regione Emilia-Romagna hanno uno stato "non buono" principalmente in conseguenza dell'evoluzione normativa, che ha visto l'introduzione di limiti nuovi o più restrittivi o di nuove matrici per la ricerca di inquinanti. Si sottolinea, per altro, che l'introduzione di nuovi requisiti normativi non deve essere erroneamente percepita come un'indicazione di deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali.
Quadro Generale
Una vasta area di territorio della regione Emilia-Romagna è coperta da zone umide, caratterizzate da una elevata variabilità ambientale e biologica. Tale area è di origine sia naturale che artificiale (lagune vive, laghi salmastri, meandri e foci fluviali, casse di espansione, invasi di ritenuta, cave di inerti dismesse, canali, saline). Per valorizzare e tutelare quest’area la Regione Emilia-Romagna ha istituito il Parco regionale del Delta del Po, con un’estensione complessiva di oltre 52.000 ettari. Le zone umide del Parco regionale rappresentano il settore meridionale del grande sistema di zone umide che caratterizza l’Adriatico settentrionale, dal Friuli fino a Cervia, e che costituisce un unico complesso sistema ecologico caratterizzato dall’esistenza di particolari associazioni vegetali e da ampi spostamenti delle popolazioni di uccelli.
Il Delta del Po ha inoltre ottenuto il riconoscimento a Riserva di Biosfera nell'ambito del Programma MaB UNESCO nel 2015. Le Riserve di Biosfera nascono per promuovere l'interazione fra l'uomo ed il proprio ambiente; esse individuano infatti in alcune aree gli ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un'appropriata gestione del territorio, si coniugano la valorizzazione dell'ecosistema e della sua biodiversità con le strategie di sviluppo sostenibile.
Gli ambienti di transizione della regione Emilia-Romagna non solo rientrano all’interno del Parco Regionale Delta del Po, ma sono: (i) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e successivamente diventati Zone Speciali di Conservazione (ZSC); (ii) Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l’avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” che ha sostituito la storica Direttiva 79/409/CEE; (iii) Zone Umide di interesse internazionale istituite dalla “Convenzione sulle Zone Umide di importanza internazionale” sottoscritta nel 1971 a Ramsar (Iran), facendo particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici.
Le zone umide comprese tra la Sacca di Goro e le Valli di Comacchio devono la loro origine all’ampio sistema deltizio del fiume Po. L’equilibrio idrogeologico dell’area è controllato dall’uomo (nota per esempio l’attività agricola e di pesca con le grandi bonifiche ferraresi); in pratica ad oggi tutte le zone umide della regione sono soggette a regimi idrici artificiali, finalizzati a diversi scopi: l’agricoltura (oggi la principale attività produttiva praticata nelle aree circostanti le acque di transizione), l’acquacoltura, la pesca e, a seguire, le attività industriali e il turismo.
Le principali problematiche delle acque di transizione dell’Emilia-Romagna si possono brevemente sintetizzare come segue:
- eccessivi apporti di sostanze nutritive (carichi di azoto e fosforo);
- forte subsidenza sia di origine antropica che naturale, che determina principalmente la perdita di porzioni di territorio;
- regressione costiera generata da fenomeni erosivi;
- scarsa disponibilità delle risorse di acqua dolce a seguito dei prelievi irrigui;
- scarsa manutenzione idraulica con conseguenti problemi di ridotta circolazione delle acque;
- progressivo aumento dell’ingressione salina in falda e nella rete idrica superficiale.
In dettaglio la rete di monitoraggio e i corpi idrici di transizione nei seguenti box:
- BOX 1 Implementazione della Direttiva 2000/60/CE alle acque di transizione
- BOX 2 I corpi idrici di transizione
Bibliografia
- 1. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
- 2. Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 3. Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
- 4. Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
Sitografia
Autori
- Elena RICCARDI (ARPAE E.R. - STRUTTURA OCEANOGRAFICA DAPHNE)
- Silvia PIGOZZI (ARPAE E.R. - STRUTTURA OCEANOGRAFICA DAPHNE)
- Cristina MAZZIOTTI (ARPAE E.R. - STRUTTURA OCEANOGRAFICA DAPHNE)
- Si ringraziano per la collaborazione e/o per i dati forniti i seguenti colleghi di Arpae Emilia-Romagna: Fabrizio Bandini, Michela Del Pasqua, Marco Lezzi, Maurizio Pascucci; Monica Raccagni. Si ringrazia Monica Carati per il supporto alle elaborazioni cartografiche. Si ringraziano inoltre tutti i collaboratori che a diverso titolo hanno contribuito alle attività di campo e di laboratorio.