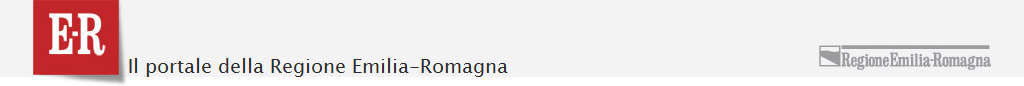Una vasta area di territorio della regione Emilia-Romagna è coperta da zone umide, caratterizzate da una elevata variabilità ambientale e biologica. Tale area è di origine sia naturale che artificiale (lagune vive, laghi salmastri, meandri e foci fluviali, casse di espansione, invasi di ritenuta, cave di inerti dismesse, canali, saline). Per valorizzare e tutelare quest’area la Regione Emilia-Romagna ha istituito il Parco regionale del Delta del Po, con un’estensione complessiva di oltre 52.000 ettari. Le zone umide del Parco regionale rappresentano il settore meridionale del grande sistema di zone umide che caratterizza l’Adriatico settentrionale, dal Friuli fino a Cervia, e che costituisce un unico complesso sistema ecologico caratterizzato dall’esistenza di particolari associazioni vegetali e da ampi spostamenti delle popolazioni di uccelli.
Il Delta del Po ha inoltre ottenuto il riconoscimento a Riserva di Biosfera nell'ambito del Programma MaB UNESCO nel 2015. Le Riserve di Biosfera nascono per promuovere l'interazione fra l'uomo ed il proprio ambiente; esse individuano infatti in alcune aree gli ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un'appropriata gestione del territorio, si coniugano la valorizzazione dell'ecosistema e della sua biodiversità con le strategie di sviluppo sostenibile.
Gli ambienti di transizione della regione Emilia-Romagna non solo rientrano all’interno del Parco Regionale Delta del Po, ma sono: (i) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e successivamente diventati Zone Speciali di Conservazione (ZSC); (ii) Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l’avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” che ha sostituito la storica Direttiva 79/409/CEE; (iii) Zone Umide di interesse internazionale istituite dalla “Convenzione sulle Zone Umide di importanza internazionale” sottoscritta nel 1971 a Ramsar (Iran), facendo particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici.
Le zone umide comprese tra la Sacca di Goro e le Valli di Comacchio devono la loro origine all’ampio sistema deltizio del fiume Po. L’equilibrio idrogeologico dell’area è controllato dall’uomo (nota per esempio l’attività agricola e di pesca con le grandi bonifiche ferraresi); in pratica ad oggi tutte le zone umide della regione sono soggette a regimi idrici artificiali, finalizzati a diversi scopi: l’agricoltura (oggi la principale attività produttiva praticata nelle aree circostanti le acque di transizione), l’acquacoltura, la pesca e, a seguire, le attività industriali e il turismo.
Le principali problematiche delle acque di transizione dell’Emilia-Romagna si possono brevemente sintetizzare come segue:
- eccessivi apporti di sostanze nutritive (carichi di azoto e fosforo);
- forte subsidenza sia di origine antropica che naturale, che determina principalmente la perdita di porzioni di territorio;
- regressione costiera generata da fenomeni erosivi;
- scarsa disponibilità delle risorse di acqua dolce a seguito dei prelievi irrigui;
- scarsa manutenzione idraulica con conseguenti problemi di ridotta circolazione delle acque;
- progressivo aumento dell’ingressione salina in falda e nella rete idrica superficiale.
In dettaglio la rete di monitoraggio e i corpi idrici di transizione nei seguenti box:
- BOX 1 Implementazione della Direttiva 2000/60/CE alle acque di transizione
- BOX 2 I corpi idrici di transizione