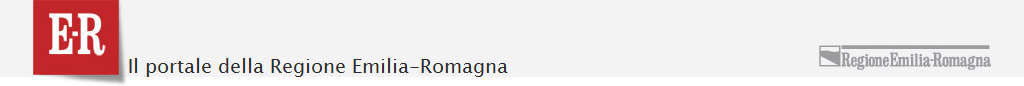La normativa nazionale inerente la prevenzione e la protezione dalle radiazioni ionizzanti ha subito cambiamenti a seguito dell'entrata in vigore, nell’agosto 2020, del DLgs 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom”. Il Decreto introduce importanti novità, concernenti, ad esempio, a situazioni di esposizione alle radiazioni ionizzanti derivanti da sorgenti naturali quali il radon e le esposizioni causate da attività con materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (NORM: Naturallly Occurring Radioactive Materials), come evidenziato dal Capo I del Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”.
In particolare, il rinnovato quadro normativo include, per la prima volta nell’ambito della protezione dall’esposizione al radon, gli ambienti residenziali (abitazioni) e prevede un nuovo e importante strumento gestionale, rappresentato dal Piano nazionale d’azione per il radon.
Dal 18/01/2023 sono entrate in vigore le modifiche del D.Lgs 101/2020, in particolar modo si cita l’art. 12. del Livelli di riferimento radon (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 7, articolo 54,comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto4 lettera a));tale articolo modifica i livelli massimi di riferimento, in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono fissati pari a 300 Bq/m-3 per i luoghi di lavoro e per le abitazioni costruite prima del 31 dicembre 2024; mentre per le abitazioni costruite dopo tale data, il livello è pari a 200 Bq/m-3.
Per la protezione dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, il Decreto Legislativo prevede obblighi sia per gli esercenti che per le Regioni, affidando nello specifico a queste ultime il compito di individuare le aree prioritarie (zone a maggiore probabilità di alte concentrazioni di attività di radon). La Regione Emilia-Romagna ha avviato dal 2001 studi mirati a ottenere una “mappatura radon” e concluso nel 2011 una campagna di misure in abitazioni individuate in corrispondenza di particolari aree territoriali (punti di emanazione gassosa/faglie affioranti).
La presenza di radioattività artificiale nell’ambiente in Emilia-Romagna, pur essendo ormai a livelli molto bassi, è tuttavia ancora riscontrabile in alcune matrici. Dal punto di vista radioprotezionistico le attuali concentrazioni dei radionuclidi artificiali conducono, comunque, a stime di dosi alla popolazione molto inferiori al limite stabilito dalla normativa italiana pari a 1 mSv/anno.
Il processo di disattivazione della centrale nucleare di Caorso e la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti, ovvero lo smantellamento di tutte le parti nucleari e la restituzione del sito, esente da vincoli radiologici, programmato fra il 2028 e il 2032, è costantemente monitorato dagli Enti/Istituzioni coinvolte anche a livello regionale (Regione, Provincia, Comuni, Arpae); sono stati infatti sottoscritti specifici Protocolli d’intesa rispettivamente tra la Provincia di Piacenza, il Comune di Caorso e Arpae Emilia-Romagna (2008) e tra Apat (oggi ISIN) e Arpae Emilia-Romagna (2005). Attualmente i rifiuti radioattivi prodotti durante l’esercizio e la disattivazione sono stoccati “provvisoriamente” in centrale; inoltre, entro il 2025, dovrebbe essere previsto il rientro in Italia in contenitori speciali dei rifiuti vetrificati derivanti dal riprocessamento degli elementi di combustibile nucleare irraggiato.
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti rappresenta, a oggi, un problema da risolvere a livello nazionale (le direttive comunitarie prevedono, infatti, che lo smaltimento dei rifiuti radioattivi sia da risolvere nell’ambito di ciascun singolo Paese): occorre procedere all’identificazione, qualificazione e messa in opera del sito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di molto bassa, bassa e media attività e per il deposito temporaneo centralizzato del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi di alta attività e a lunghissima vita. La disponibilità di un tale sito è, infatti, condizione indispensabile per garantire una effettiva e corretta gestione dello smantellamento delle centrali nucleari italiane e per il corretto smaltimento dei rifiuti provenienti dalle altre applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare (industriali e mediche).
Concernente all’identificazione del sito del deposito nazionale si riporta quanto scritto sul sito dedicato https://www.depositonazionale.it/:
“Il 13 dicembre 2023 il MASE ha pubblicato sul proprio sito web l’elenco delle aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI),aprendo una fase di invio di autocandidature ad ospitare l’opera da parte degli Enti locali di tutto il territorio italiano. Alla scadenza del termine (12 marzo 2024) non si sono registrate autocandidature.
L'iter di localizzazione del sito idoneo a ospitare il DNPT prosegue pertanto, come previsto dal Decreto, con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulla proposta di CNAI, avviata da MASE con il supporto tecnico di Sogin.”
Stante l’attuale situazione, è prevedibile, nei prossimi anni, una crescita delle quantità di rifiuti radioattivi presenti negli attuali siti “temporanei” di detenzione, con l’avvio delle attività di smantellamento delle installazioni nucleari italiane; l’iter di individuazione e della successiva costruzione del sito nazionale, anche nella più ottimistica delle ipotesi, necessiterà infatti ancora di diversi anni.